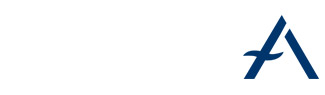SET
15
2016
Roland in confronto alla nostra miseria
Sento a volte parlare di Roland Barthes. Si tratta di un nome di per sé affascinante; un po’ per il suono francese, un po’ perché l’ultimo fonema che caratterizza il cognome crea una sospensione, un’attesa seducente e ammiccante, un po’ perché il nostro è nominato in una canzone di Francesco Guccini (peraltro correttamente correlato, all’interno della canzone, con la corrente strutturalista).
Ovviamente lo si sente citare in relazione a frasette estrapolate e riportate per fare effetto, … per condire il cognome si direbbe.
Nessuno ha il coraggio di trattare, soprattutto in pubblico, effettivamente, ad esempio, del carattere inconscio della lingua che lega Saussure, Lacan, Lévi-Strauss fino a Jung così come è praticamente impossibile udire una spiegazione del concetto di
catena semiologica seconda o di
idioletto (… idioletto estetico il concetto caro a Eco). Niente relazioni con l’allievo Todorov o con i
formalisti russi. Tantomeno si porranno relazioni tra teorizzazioni limitrofe come quelle di Marshall McLuhan sui media o di Richard Dawkins sulla memetica.
Il fatto è che per maneggiare Barthes ci vogliono gli attributi; si tratta, infatti, di un lavoro faticoso, sia perché l’autore presuppone conoscenze di estensione non indifferente, sia perché scrive un po’ … come Freud. Io ci sono affezionato a Roland, non solo per il livello della sua cultura, ma anche perché, ad esempio, è uno studioso in grado di capire quanto anticipatorio sia il testo
Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola.
Inoltre è impossibile parlare del semiologo francese senza aver STUDIATO almeno i seguenti libri:
Elementi di semiologia,
Miti d’oggi,
L’impero dei segni,
L’ovvio e l’ottuso,
La camera chiara e il testo di cui tratterò oggi,
Critica e verità (più tutto quello che si deve studiare prima per capirlo).
In questo periodo di oltraggio alla cultura e alle buone prassi per la gestione dell’informazione e della comunicazione, in quest’era di cialtroni superficiali che scambiano le vicende storiche del Cile con quelle del Venezuela, ho scelto di riportare un ragionamento sul rispetto del libro e della cultura nel Medioevo (prendetemi così come sono … oggi mi sono rovinato la giornata a causa del fatto che un giornalista radiofonico ha “spiegato” che i termini “tautologia” e “ovvietà” sono sinonimi).
Barthes nota che nel periodo storico citato il rapporto tra libro (cultura) e coloro che la trattavano in funzione di una nuova eventuale poiesi di senso da rappresentare al fruitore era strettamente regolamentato. Si articolavano, appunto, attorno al libro quattro figure distinte: lo
scriptor (che ricopiava senza aggiungere nulla), il
compilator (che ricopiava senza aggiungere nulla di suo), il
commentator (che interveniva di propria iniziativa nel testo ricopiato solo per renderlo intelligibile), e infine
l’auctor (che presentava le proprie idee, basandosi sempre su altre autorità). (Abbiamo riportato praticamente il testo originale dell’autore).
Si tratta di un articolazione tesa al rispetto di un contenuto (culturale), ma, foriera, anche, di un altro concetto: devi avere un permesso implicito per trattare l’informazione e presentarla agli altri; non puoi essere una nullità culturale, dimostrarlo, ed avere ancora il permesso di esercitare un ruolo (critico) sul processo di elaborazione dell’informazione. Insomma, se sei un ignorante grasso pazienza, capita, ma per favore stai a casa, non fare l’opinion leader sui social e, se puoi, tanto meno il politico!
Conclude il saggio Barthes: “… Quanti scrittori hanno scritto solo per aver letto? Quanti critici hanno letto solo per scrivere? …”. Quanti politicucci parlano per dare aria alla bocca pensando di essere tanto belli? … aggiungo io?